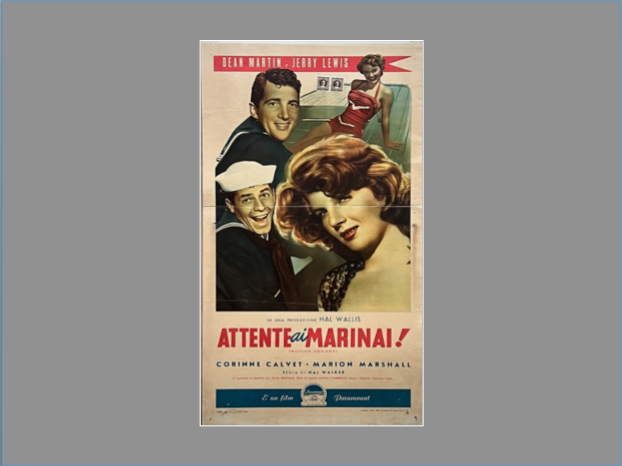L’ULTIMA DUE CAVALLI
27 luglio 1990. Dalla catena di montaggio esce l'ultima Citroen 2CV, l'auto Hippy per eccellenza assieme al Pulmino Volkswagen Transporter. Il progetto dell'auto è del 1935, ma il debutto sul mercato avviene solo nel dopoguerra. Autore della design è l'italiano Flaminio Bertoni.
La due Cavalli era stata presentata il 7 ottobre 1948 a Parigi. Sì, stiamo parlando proprio di quella piccola berlina francese che sta alla Francia come la Topolino all’Italia e il maggiolino alla Germania; anche perché la loro origine ha qualcosa in comune. Ci troviamo nell’Europa negli anni 30-40 quando i vari governi decisero di produrre un’auto che motorizzasse il paese.
L’idea della 2CV nasce in vacanza. Pierre-Jules Boulanger, ai vertici della Citroen, decise di concedersi un periodo di riposo in Auvergne, regione agricola al centro della Francia. Là si accorse come nessun contadino possedesse un’auto, così si appuntò: «Voglio quattro ruote sotto un ombrello, capaci di trasportare una coppia di contadini, cinquanta chili di patate e un paniere di uova attraverso un campo arato, senza romperne uno». Pare che la velocità massima dovesse essere di 60 km/h. Pierre-Jules provò vari prototipi, sempre indossando il cappello dei contadini; ma la guerra incombeva. I tedeschi invasero la Francia e lui diede ordine di distruggere quanto era stato progettato, compresi i modelli realizzati, un po’ bruttini a dire il vero.
Nel 1945, a fine conflitto, Boulanger decide di abbellire la futura 2CV e convoca lo stilista italiano Flaminio Bertoni. Quest’ultimo aveva già disegnato la Traction e più tardi avrebbe progettato anche la DS. Lo stilista italiano completa l’idea con tutta la simpatia necessaria. I contadini trasportabili diventano quattro, pur con patate e uova.
Nonostante le critiche negative, la 2CV ottiene un successo immediato. L’auto è economica, molto; e Boulanger suggerisce di privilegiare, nella vendita, coloro che non possono permettersi un modello normale.
In totale, 5.114.969 sono state le unità prodotte, di cui 1.246.335 in versione furgone, tra il 1948 e il 1990. Divenne l’auto simbolo degli studenti di sinistra durante le proteste del Sessantotto e il sogno di molti giovani.